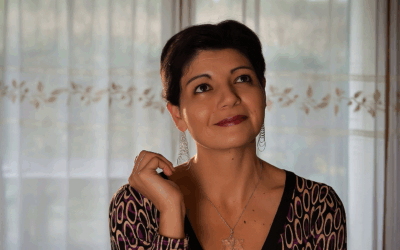Oggi abbiamo il piacere di ospitare un ospite speciale qui a La favola del successo. Si tratta di Matteo Rigotti, chitarrista e compositore di altissimo livello. È qui con noi per raccontarci la sua storia, ma soprattutto per spiegarci a cosa serve la musica, quali emozioni riesce a suscitare e in che modo può essere utile, per davvero, nella vita delle persone.
Ciao Matteo, benvenuto. Iniziamo subito con una riflessione che ci sta particolarmente a cuore: la musica ha la straordinaria capacità di cambiare l’umore in modo quasi istantaneo. Tra tutti gli stimoli sensoriali è forse il più rapido nel trasformare ciò che proviamo dentro. Ti va di raccontarci il tuo punto di vista?
“Assolutamente sì. Penso che la musica sia una delle forme d’arte più potenti per influenzare il nostro stato d’animo. Ogni suono, ogni melodia, può interagire con noi in maniera profonda. Se stiamo vivendo una giornata triste, una canzone può aiutarci ad affrontare quel momento, oppure intensificare quella tristezza rendendola in qualche modo più consapevole. Al contrario, se siamo felici, la musica può amplificare quella gioia, portandoci a uno stato quasi euforico. È una forma d’arte che si insinua nell’animo con naturalezza e immediatezza”.
Hai detto una cosa interessante: può enfatizzare uno stato d’animo, non solo cambiarlo. In effetti, c’è una parola bellissima ma desueta: tripudio. Sai, immaginiamo un bambino che salta dalla felicità, muovendosi così velocemente da sembrare che abbia tre gambe. È l’effetto che dà la musica, no?
“Verissimo. La musica non si limita all’aspetto emotivo o mentale. È connessa direttamente al corpo. I ritmi influenzano i nostri movimenti, il nostro respiro, persino la postura. Ci sono studi che dimostrano scientificamente quanto i suoni abbiano un impatto profondo sia sul piano fisico che mentale. Il corpo “risuona” con la musica. Non è solo un’esperienza uditiva: è un’esperienza totale”.
Non a caso l’udito è tra i primi sensi a svilupparsi. Ancora nel grembo materno, il feto percepisce le vibrazioni, i suoni del corpo della madre, il respiro, i battiti del cuore. È come se fossimo fin dall’inizio predisposti a farci guidare dai suoni per generare emozioni…
“Esatto. I suoni ci accompagnano fin dalla vita prenatale, e probabilmente è per questo che siamo così sensibili alla musica. È un canale emotivo primordiale. E anche quando la musica non accompagna immagini, come accade nei film, riesce comunque a raccontare, a suggerire emozioni e pensieri, a trasportare chi ascolta in un universo interiore”.
Parlando della tua produzione, hai ricordato l’immagine dello scultore che plasma la materia. In questo caso, la tua materia è il suono. Hai anche accennato a un processo di trasformazione, dove talvolta parti da materiale altrui per creare qualcosa di nuovo. Ci spieghi meglio?
“In un certo senso mi sento uno scultore sonoro. Non necessariamente nel senso di rielaborare lavori di altri, ma più nel modo in cui cerco di modellare la materia sonora per darle una forma espressiva nuova. Anche se la mia musica non è strettamente legata al cinema, come la musica da film, ne condivide l’obiettivo: evocare emozioni, creare atmosfere. Solo che nel mio caso il viaggio emotivo è più astratto, più mentale, perché spesso è scollegato da immagini visive”.
Se ci pensi, anche alcune opere classiche come Le Quattro Stagioni di Vivaldi hanno questa funzione. Guidano chi ascolta attraverso un percorso emozionale legato ai mutamenti della natura e del clima. La musica, insomma, diventa una guida…
“È un ottimo esempio. Vivaldi, con quell’opera, ci fa vivere le stagioni come se fossero stazioni dell’anima. Il passaggio dalla primavera all’inverno non è solo meteorologico, è anche emotivo. E in effetti, la mia musica cerca di fare qualcosa di simile, ma su un piano più contemporaneo. Propongo un ascolto che possa accompagnare l’ascoltatore da uno stato emotivo all’altro, offrendo uno spazio per fermarsi, riflettere e sentirsi”.
Questo ci porta a una riflessione sulla tua musica, che si potrebbe definire “colta”, nel senso più nobile del termine. Non commerciale, certo, ma nemmeno elitaria. Abbiamo ascoltato alcune tue composizioni e le abbiamo trovate non solo raffinate, ma anche profondamente accessibili. È un’impressione corretta?
“Quando dico che la mia è musica “colta”, non lo faccio con intenzione snob. Semplicemente, è un tipo di musica che richiede un diverso atteggiamento da parte dell’ascoltatore. Non è qualcosa che si può assorbire distrattamente, come capita magari con la musica pop che accompagna altre attività. Qui si tratta di dedicare un tempo esclusivo, di creare uno spazio mentale per l’ascolto, proprio come accade visitando una mostra d’arte. È un’esperienza meditativa, se vogliamo”.
Quindi è una musica che si gusta lentamente, come un liquore da meditazione. Non da bar, ma da degustare in silenzio, a una temperatura precisa, lasciando che il profumo e il gusto emergano a poco a poco. L’analogia funziona?
“Direi che è calzante. Come un buon distillato, anche la mia musica richiede attenzione e pazienza. Non cerca l’impatto immediato, ma una comprensione graduale. Per questo parlo spesso di introspezione: è un ascolto che si rivolge più all’interiorità che all’esterno”.
Questo però ci pone davanti a una sfida. Oggi viviamo in una società in cui tutto è rapido, liquido, come direbbe Bauman. L’idea di fermarsi a contemplare, a sentire, a riflettere, sembra quasi un atto rivoluzionario!
“Lo è, in effetti. Siamo abituati a vivere tutto in multitasking, anche l’arte. Ma penso che sia proprio questa la forza della musica colta: ci obbliga a rallentare. A prenderci quel tempo per noi stessi, per ascoltare davvero. E forse, proprio per questo, può avere una funzione terapeutica”.
Quindi potremmo dire che ascoltare la tua musica è un gesto di cura. Verso se stessi, prima di tutto?
“È un atto di presenza, di consapevolezza. È come dirsi: “Adesso mi fermo, ascolto, sento”. In un’epoca come la nostra, in cui spesso siamo disconnessi da noi stessi, questa è una pratica preziosa”.
Parliamo anche dell’aspetto didattico. Tu sei anche docente, e quindi conosci bene il valore della divulgazione. Non pensi che una maggiore alfabetizzazione musicale, anche minima, potrebbe aiutare tante persone a entrare più profondamente in questo mondo?
“Assolutamente sì. Io credo che una delle barriere principali tra le persone e la musica cosiddetta “difficile” sia proprio la mancanza di strumenti di comprensione. Non parlo di nozioni accademiche, ma di chiavi di lettura. Un po’ come per l’arte figurativa: se guardi un quadro di Van Gogh senza sapere nulla della sua storia, ti perdi metà dell’esperienza. Lo stesso vale per la musica”.
A volte basta poco per accendere la curiosità. Magari uno ascolta una canzone che gli piace, ma non sa spiegarsi il perché. Se però avesse qualche “strumento per capire gli strumenti”, per citare una tua bella espressione, forse quel piacere diventerebbe più consapevole…
“È un gioco di parole interessante, e anche molto profondo. Lo strumento, nel senso musicale, è anche un mezzo. Una voce che parla senza parole. Se impariamo a comprenderne il linguaggio, anche solo in modo basilare, la nostra esperienza cambia radicalmente. Capire, ad esempio, come funziona la cassa armonica di una chitarra, o perché certi suoni ci emozionano, significa arricchire il nostro ascolto”.
Quindi ascoltare diventa qualcosa di attivo, non più passivo. Ci sono persone che magari sentono una melodia e si commuovono, ma non sanno che dietro quel passaggio ci sono scelte precise: tonalità, ritmo, dinamiche. Non serve diventare musicologi, ma conoscere qualcosa in più rende tutto più vivo. Concordi?
“Esattamente. È come per il vino: puoi berlo e dire “mi piace”, ma se conosci le uve, i metodi di vinificazione, il territorio… tutto acquista una nuova profondità. Lo stesso vale per la musica. Anche la musica popolare ha una sua complessità. Ci sono riferimenti storici, influenze, strutture armoniche che spesso si perdono senza una minima guida”.
Spesso, ascoltando con attenzione, si scoprono rimandi nascosti. Per esempio, molti brani contemporanei si basano su campionamenti di pezzi degli anni ’70 o su armonie classiche. Se non conosci quelle radici, pensi che siano cose nuove, ma in realtà…
“In realtà c’è tutto un mondo dietro. Stratificazioni, citazioni, influenze che si intrecciano. È un po’ come fare un’analisi al carbonio-14 della musica. Andare in profondità, scavare negli anelli di crescita, come si fa con un albero. Questo è affascinante e può diventare una chiave educativa molto forte, specialmente per i giovani”.
Parlavi prima della scuola. In effetti, nelle scuole dell’obbligo, la musica è spesso considerata una materia minore. Un’ora di svago più che di formazione. Ma questo è un errore, no?
“Purtroppo sì. Ho insegnato per molti anni nelle scuole dell’obbligo, e spesso la musica veniva vista come un diversivo, una pausa. Ma la musica è un linguaggio, uno strumento per leggere il mondo e per conoscersi. È anche un modo per uscire dal proprio guscio, per esprimersi, per comunicare in modo non verbale. E questo è fondamentale, soprattutto oggi”.
Oggi che, come hai detto tu, c’è una certa chiusura. L’epoca post-Covid ha lasciato segni profondi nei ragazzi. Molti fanno fatica a relazionarsi, a esternare ciò che provano…
“Infatti, e la musica può aiutare da questo punto di vista. È un linguaggio universale, che consente di entrare in contatto con sé stessi e con gli altri. Per chi è timido, o per chi ha difficoltà ad aprirsi, può essere un veicolo straordinario di espressione e anche di guarigione emotiva. Per questo dico che è anche terapeutica”.
Il pensiero corre a quei ragazzi che in adolescenza scrivono versi o testi confusi, pieni di emozioni che non riescono a incanalare. La musica, in quel momento, può diventare un catalizzatore, uno strumento per organizzare quel caos interiore?
“Certamente sì. Molti giovani si avvicinano alla musica proprio per questo. È un mezzo per mettere ordine dentro di sé. Anche solo pizzicare le corde di uno strumento, senza sapere leggere uno spartito, può essere un atto creativo e liberatorio. Il gesto stesso di produrre un suono è una forma di affermazione, un “ci sono”, un “sto cercando un modo per dire qualcosa”.
Ecco perché è così importante dare ai ragazzi strumenti, anche solo iniziali, per avvicinarsi alla musica. Non si tratta di formare professionisti, ma di educare all’ascolto e all’espressione. In questo senso, il tuo progetto, il tuo libro che qui stiamo immaginando – e di cui, come sempre abbiamo già immaginato un titolo, ovvero “Strumenti per capire gli strumenti” – potrebbe davvero essere un’opera divulgativa preziosa…
“È proprio ciò che spero. Non voglio scrivere un trattato per addetti ai lavori. Voglio offrire delle chiavi di accesso, dei percorsi semplici che possano accendere la curiosità. Come dicevamo prima: non serve conoscere la teoria musicale nei dettagli, basta avere qualche strumento per aprire l’ascolto. Anche solo il fatto di sapere che una determinata sonorità nasce da una precisa scelta compositiva può trasformare completamente l’esperienza”.
Anche perché, diciamolo, oggi l’intelligenza artificiale sta entrando anche nel campo della musica. Alcuni pezzi sono scritti da algoritmi. Senza un minimo di cultura, come si fa a distinguere ciò che ha valore umano da ciò che è solo prodotto automatizzato?
“Questo è un punto molto delicato. La tecnologia può essere uno strumento potente, ma senza una base culturale rischia di trasformarsi in un inganno. Chi non ha gli strumenti per discernere, finisce per accettare tutto, per aderire a mode che non sa nemmeno spiegare. La conoscenza è ciò che ci permette di avere una visione critica, di non essere travolti da ciò che ci viene proposto”.
E allora il tuo libro, questa intervista, il tuo lavoro diventano un atto di resistenza. Una proposta alternativa al consumo passivo. Un invito a tornare a “sentire”, nel senso più pieno del termine!
“Sì, esatto. Un invito ad ascoltare con consapevolezza, a lasciarsi toccare, ma anche a interrogarsi. A chiedersi perché ci piace un certo brano, cosa ci fa sentire. E magari a scoprire che c’è molto di più dietro quelle note. C’è una storia, una tecnica, un’intenzione. E soprattutto, c’è spazio per noi, per le nostre emozioni”.
È molto bello questo approccio. Hai parlato spesso di “spazio per le emozioni” e credo sia proprio questa la chiave. La tua musica offre uno spazio, una pausa nella frenesia quotidiana. Potremmo definirla come una parentesi aperta nel rumore di fondo?
“Penso che la musica – soprattutto quella non commerciale, non pensata per il consumo veloce – debba creare delle pause. Delle fenditure nel tempo. Oggi tutti corriamo, viviamo bombardati da input, da immagini, da richieste. Fermarsi ad ascoltare un brano che non ha un ritornello o una melodia immediata diventa un gesto controcorrente. Ma proprio per questo è prezioso”.
Il tuo messaggio è chiaro: la musica non è solo intrattenimento. È anche formazione, educazione, scoperta. È una lente per osservare sé stessi e il mondo con maggiore attenzione.
“Sì. E, se posso aggiungere un’ultima cosa, direi che la musica è anche un’opportunità per stare insieme. Anche nei miei percorsi didattici cerco sempre di favorire la condivisione, il dialogo. La musica non ha bisogno di parole, ma crea comunicazione. È uno strumento di relazione, di empatia”.
Matteo, ti ringraziamo per questa bellissima conversazione. È stato un viaggio affascinante tra emozioni, conoscenza e suono. Siamo certi che chi ci legge porterà con sé molte suggestioni e, magari, anche il desiderio di ascoltare in modo diverso, più profondo.
“Grazie, è stato un grande piacere! Spero davvero che questa chiacchierata possa essere utile, e magari stimolare qualcuno a scoprire nuovi mondi musicali. Basta poco: un orecchio attento, una mente aperta, e tutto cambia”.